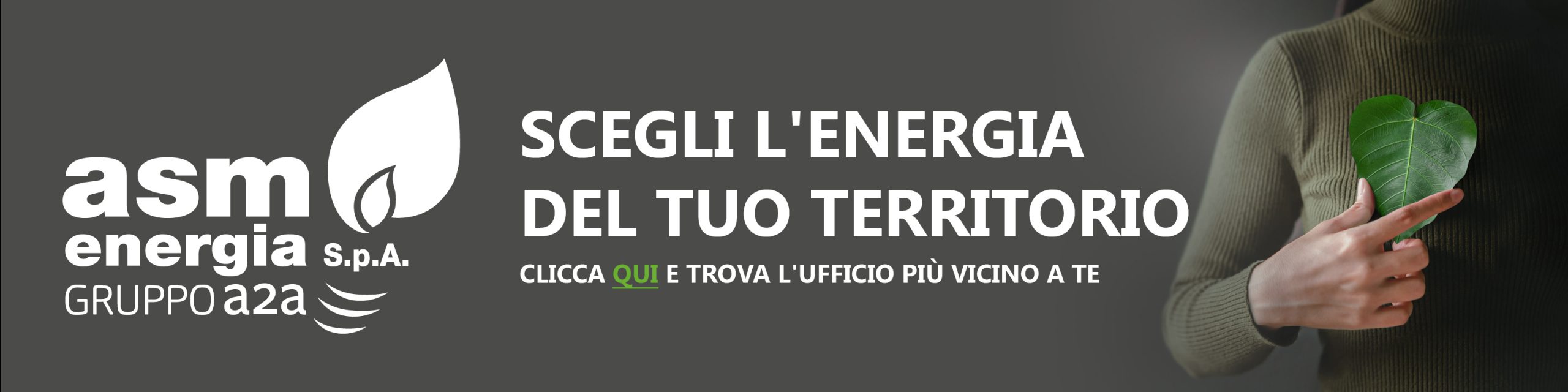A cura di Alessandra Restelli e Maria Luisa Siviero
Nel linguaggio sintetico delle aste, i ditali si inseriscono nella generica definizione di “oggetti di virtù”, un termine che storicamente ha fatto riferimento a manufatti dotati di qualità magiche o di particolare influenza su chi ne deteneva il possesso. In Toscana era denominato “anello da cucire”, evidenziando così la connessione con altri anelli, carichi di significati più profondi e simbolici.
Con il passare del tempo, il ditale è stato spesso associato all’arte del cucito e alla raffinatezza tipica degli accessori casalinghi. Il periodo compreso tra il 700 e l’800 rappresenta un momento cruciale: quelli in argento, particolarmente ricercati, richiedevano un sistema di controllo tanto che in Gran Bretagna nel 1883 fu introdotta l’obbligatorietà della numerazione e registrazione di ogni pezzo prodotto. La varietà dei materiali utilizzati si è via via ampliata: esistono esemplari in vetro, madreperla, tartaruga e legno, alcuni ornati con pietre preziose. A differenza di altri oggetti in oro e argento, non è possibile fare riferimento ai punzoni per la loro autenticazione. Infatti, una legge anglosassone del 1738 esentava il fabbricante dall’obbligo di apporre il marchio per ditali e altri oggetti con peso inferiore a 16 grammi. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di recuperarne e conservarne in Collezione 75 per la precisione; di varie forme e fogge, trovati all’interno di cassettoni o comò insieme a fili da ricamo e altri attrezzi per il cucito o dentro a deliziose scatole da pasticceria mentre i più “preziosi” racchiusi in scatoline di vetro con nastri di seta eseguiti dalle suore o in piccoli scrigni d’argento con la chiave (solitamente dati in dono dalla mamma alla figlia)