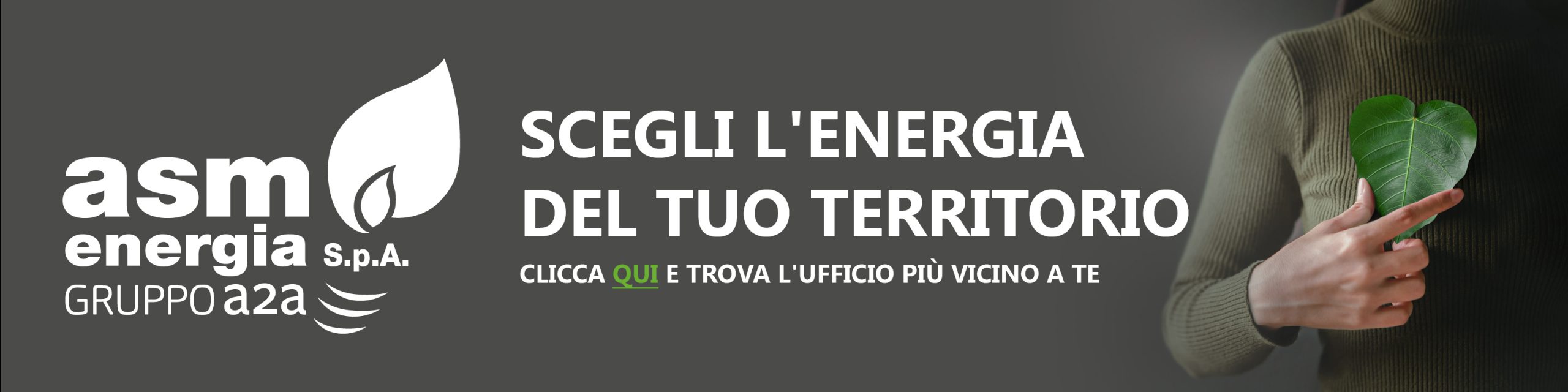L’attuale presidente di AmiCivico alle prese con l’interruzione forzata
dei movimenti culturali e con le nuove esperienze tecnologiche
Nessuno come Maria Forni può cercare di indagare sulla situazione della nostra società e del nostro animo in questo momento della storia. Dopo essere stata insegnante al liceo di Vigevano è nominata preside (indimenticata) all’Omodeo di Mortara. Non ha mai abbandonato il mondo della scuola, di cui è tuttora profonda conoscitrice e resta un punto fermo per l’analisi del panorama e dei movimenti culturali mortaresi e lomellini. Inoltre è presidente dell’Associazione AmiCivico che sostiene l’attività della biblioteca di Mortara, uno dei centri d’eccellenza delle attività letterarie e sociali del territorio. A Maria Forni abbiamo chiesto di interpretare il momento attuale dominato dalla pandemia .
L’insegnante e la donna di cultura, pur essendo preparata dalla storia, avrebbe mai immaginato una situazione come quella che stiamo vivendo? È una normalità che prima o poi avremmo dovuto mettere in conto?
La storia dovrebbe insegnare molte cose, ma forse, come dice Montale, non è magistra di niente che ci riguardi. Infatti, col senno di poi, posso affermare che si sarebbe ben potuta prevedere l’eventualità di una situazione pandemica. Bastava un po’ di lungimiranza, considerando tutti i fattori coinvolti, quali la globalizzazione, il cambiamento climatico, gli scarsi scrupoli di fronte al guadagno e altro ancora. Avrei dovuto mettere in conto i corsi e i ricorsi vichiani e attendere prima o poi la famosa “scopa” di Don Abbondio, ma, come spesso avviene, immersa nel presente e nella girandola di impegni pratici, sono stata colta di sorpresa da questa esperienza fortemente diversa dal nostro mondo abituale.
Veniamo alla nostra vita di tutti i giorni e ai comportamenti che notiamo vicino a noi. Quale è il giudizio su quel che sta succedendo?
La vita è cambiata molto, sembra assurdo non poter uscire liberamente, non stare con gli altri: un incubo distopico forse anticipato dalla fantascienza. Ritengo ovviamente giuste le limitazioni imposte: troppi sono comunque i morti e i drammi affettivi ed economici che colpiscono le famiglie e il Paese. Le persone hanno per lo più accettato abbastanza bene la situazione, cercando anche di trovare motivazioni di senso e impegni diversi all’interno delle proprie case.
Per arrivare alla cultura e alle nostre abitudini: librerie aperte, biblioteche aperte che facevano parte del nostro mondo quotidiano. Ora, invece, tutto chiuso. E quando ci riprenderemo come sarà? Il nostro mondo tornerà esattamente come prima?
L’interruzione forzata dei momenti culturali che ci arricchivano la vita in occasioni di incontro e di dialogo è uno degli aspetti per me più difficili da affrontare. Nostalgia di un luogo dove sfogliare i libri appena usciti e scambiare impressioni e commenti con persone amiche. Un importante “pezzo della mia vita” è trascorso nella Biblioteca civica, nelle librerie passate e presenti, nelle attività della parola condivisa e della comunicazione sul “filo del discorso”. Non so se tutto tornerà come prima, certo si uscirà dalla presente situazione, ma l’incertezza sul “quando” impedisce anche l’effettiva costruzione mentale e progettuale di immagini del futuro prossimo.
Qualcosa di buono questo pandemonio ci ha lasciato? L’utilizzo dei sistemi multimediali e dei social, nelle presentazioni di un libro o di un evento, la mostra interattiva visibile su internet ci hanno dato un’accelerazione positiva?
Li apprezzo perchè non possiamo tornare indietro nel tempo e oggi sono un’interessante aggiunta alle conoscenze e alle informazioni. Ma il rapporto diretto con l’opera e con un’autore non può essere superato da nulla. Rimanere davanti a un dipinto e vederne l’aspetto materico ci consente di capire e interpretare il mondo dell’autore senza filtri. L’ultimo ricordo è la mostra sui divisionisti che ho visitato a Novara a febbraio, appena prima della chiusura, che mi ha tenuta incantata di fronte a quadri meravigliosi.
Come supereremo, dentro di noi, questa vicenda?
Un’esperienza così sconvolgente e totalizzante difficilmente potrà essere superata come se nulla fosse accaduto: la storia ogni tanto fa un “salto”, imprime all’umanità uno scossone. In questi punti di discontinuità avvengono i cambiamenti, che possono essere pure di segno opposto. Così, anche questo metaforico terremoto ha presentato un volto oscuro, opaco e non privo di aspetti tragici, ma ha costretto molti di noi a riflettere sul nostro sistema socio-politico, sulle sue carenze e falle, sulle eccessive diseguaglianze. Non vorrei cadere nella retorica, ma è innegabile che gli automezzi militari carichi di bare anonime, abbiano scosso gli uomini del XXI secolo, soprattutto nel mondo occidentale, dai loro deliri di onnipotenza e dalle sicurezze dovute al benessere. Le due immagini di questa pandemia che nessuno mai dimenticherà saranno quelle dei medici vestiti dei loro camici e maschere in terapia intensiva e dall’altra i camion pieni di bare che uscivano da Bergamo. Immagini sconvolgenti. Non ce ne dobbiamo dimenticare.
In questo campo anche la scuola (e l’industria con lo smart working) sta facendo un esperimento mai vissuto. Lezioni e insegnamenti on line. È positivo? Oggi è inevitabile, ma ci porteremo dietro questa esperienza anche per il futuro?
La scuola a distanza, il lavoro a casa propria, le visite a musei e a luoghi artistici attraverso la rete sono di grande utilità sociale, contribuendo in modo determinante sia a salvare la continuità dell’apprendimento scolastico sia a mantenere viva la cultura della bellezza. Senza questi strumenti sarebbe stata davvero gravissima la situazione scolastica con gli alunni abbandonati a sè stessi e l’improvvisa cesura nella formazione dei giovani. Pur apprezzando quindi il grande sforzo sostenuto dalle istituzioni scolastiche e culturali, che ha garantito una continuità di conoscenza e di impegno, non credo che la scuola adempia pienamente la sua funzione formativa senza la presenza di una concreta e reale comunità di persone vive e vere. Penso bensì che l’uso della didattica a distanza abbia stimolato il mondo della scuola a trovare forme e metodi nuovi, adatti appunto ai ragazzi del nuovo millennio e ai loro ritmi di apprendimento. Non mettiamo dunque in soffitta l’elettronica scolastica, una volta tornati a una nuova e diversa “normalità”, ma non usiamola da lontano, per sopperire a una necessità: usiamola piuttosto in un’aula piena di bambini e di ragazzi, posti davanti ai loro schermi, ma in carne, ossa, voce e vivacità, disponibili ad apprendere e pronti all’amicizia e alla socialità.
Uno degli scogli che molti giovani dovranno affrontare sarà l’esame di maturità: Quali considerazioni si possono fare in base alle ultime disposizioni previste dal Ministero?
È evidente che non si potrà attuare la forma tradizionale della prova, gli scritti non si faranno per evidenti ragioni di sicurezza. L’orale tuttavia, organizzato con le necessarie cautele, potrebbe attuarsi non a distanza, ma in presenza, come chiede nel suo recente appello lo scrittore Paolo Giordano e come vorrebbero moltissimi ragazzi che hanno scritto in proposito alla ministra dell’Istruzione. Gli studenti chiedono in sostanza di non essere privati di una conclusione del loro percorso svolta nella realtà della loro scuola, nell’edificio dove hanno studiato per anni, tra gioie e difficoltà, alla conquista di quella formazione che li accoglie nell’età adulta. Si tratta di un rito di passaggio, di un momento importante, unico nella vita: conforta sapere che gli studenti non vogliono rinunciarvi, pur consapevoli di una necessaria “edizione ridotta”. Ridotta sì, ma nella loro scuola e in un colloquio diretto con i loro docenti: la scuola è soprattutto una comunità, segnata dalla partecipazione e dalla condivisione.