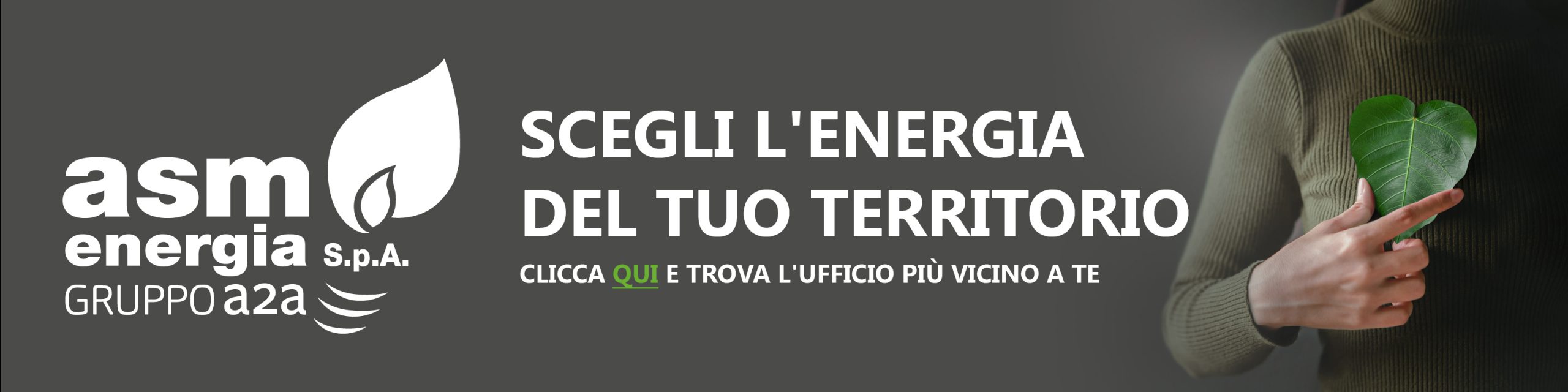A cura di Simone Tabarini
Sfogliando le antiche mappe catastali della Lomellina compaiono spesso nomi che paiono riferirsi a paesi scomparsi, ma in realtà designavano cascine: grandi complessi rurali che, per estensione e numero di abitanti, potevano sembrare piccoli villaggi. Non erano semplici poderi isolati, bensì corti chiuse organizzate attorno a un ampio cortile centrale, circondate da abitazioni, stalle, fienili, granai, laboratori artigiani e, talvolta, cappelle o piccoli conventi che rafforzavano il senso di comunità. Dal Quattrocento, e soprattutto nel Cinquecento, la diffusione del riso trasformò il paesaggio e favorì la nascita di cascine sempre più grandi e strutturate. Alcune, come il Colombarone della Sforzesca a Vigevano, divennero modelli capaci di ospitare numerosi lavoratori, garantire protezione. Nei secoli successivi, con la “rivoluzione agricola”, le cascine si modernizzarono, divenendo centri produttivi in grado di rifornire non solo i mercati locali ma anche le città in crescita. Per generazioni furono il cuore pulsante della Lomellina, assicurando lavoro e sostentamento a centinaia di famiglie. Il declino arrivò tra Ottocento e Novecento, quando industrializzazione e vita urbana attrassero la manodopera con salari migliori e condizioni meno dure. Già a metà del Novecento molte cascine erano spopolate: alcune ridotte a depositi, altre abbandonate o demolite. Eppure, anche in rovina, restano testimoni silenziosi di una storia collettiva. Custodiscono la memoria di uomini e donne che, attraverso il lavoro e la solidarietà della corte, hanno forgiato l’identità lomellina.