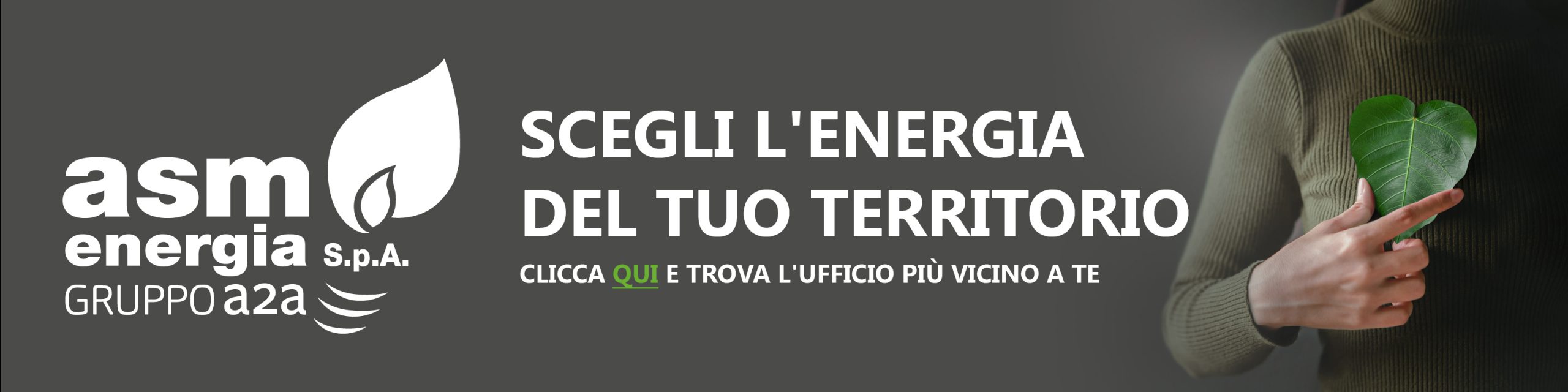A cura di Simone Tabarini
Tra XVI e XVII secolo anche la Lomellina fu attraversata dalla caccia alle streghe. Non fu un’ondata feroce come in altre regioni d’Europa, ma una repressione lenta e silenziosa, radicata nella religiosità popolare e nel controllo inquisitoriale del Ducato di Milano. In un mondo rurale dove sacro e profano convivevano, bastava poco per far nascere un’accusa: un raccolto andato male, una malattia improvvisa, uno sguardo giudicato malevolo. Le sospettate erano quasi sempre donne: vedove, levatrici, guaritrici, figure marginali, spesso depositarie di saperi antichi. A Mede, nel 1594, una donna fu processata per aver usato erbe curative: costretta ad abiurare pubblicamente, fu esiliata. A Mortara, nel 1621, Caterina fu imprigionata per aver “guardato male” un neonato morto pochi giorni dopo. A Lomello, nel 1608, una levatrice fu accusata di praticare riti notturni e venne allontanata dalla comunità. A Vigevano, dove risiedeva il vescovo e operava il tribunale ecclesiastico, i processi contro donne che curavano persone e animali con infusi portarono alla proibizione di ogni pratica senza controllo clericale. Le pene non erano sempre il rogo: più spesso si trattava di abiure, esili, isolamento sociale. Ma la punizione più profonda era il sospetto: una ferita invisibile che cancellava identità e storie. I documenti conservati negli archivi di Vigevano e Milano restituiscono oggi un quadro frammentario ma eloquente. Raccontare quei processi significa ridare voce a chi fu condannato prima ancora di parlare, in un’epoca in cui il silenzio era l’unico rifugio possibile.